Vinitaly Alta Gamma 2025: sfide e strategie per i vini italiani
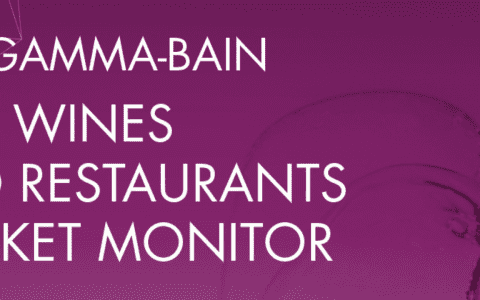
Dal monitor Altagamma-Bain al dibattito con i protagonisti a Vinitaly: analisi approfondita su comunicazione, ristorazione e futuro dell’alta gamma Made in Italy.
Nel complesso e sfavillante universo del lusso globale, un settore che sfiora i 1.500 miliardi di euro, i vini di alta gamma si ritagliano un ruolo di primissimo piano, agendo come potenti simboli di qualità, esclusività e piacere. Con un valore stimato di 30 miliardi di euro nel 2024, questo segmento, pur minoritario in volume (1,5% del totale vino), è un concentrato di valore economico (11% del totale) e culturale, indissolubilmente legato al mondo dell’alta ristorazione. Quest’ultima, un mercato da 28 miliardi in crescita esponenziale (+27% dal 2022), trova nei vini di alta gamma non solo un complemento, ma un motore essenziale, capace di generare fino al 40% dei ricavi attraverso abbinamenti e proposte mirate.
Questo scenario dinamico è stato l’oggetto del primo, inedito Altagamma-Bain Fine Wines and Restaurants Market Monitor, presentato nel contesto strategico della 57ª edizione di Vinitaly. Lo studio è frutto della collaborazione tra Fondazione Altagamma, l’istituzione che dal 1992 riunisce e rappresenta le eccellenze dell’industria culturale e creativa italiana (dalla moda al design, dall’alimentare all’ospitalità) agendo come ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, e Bain & Company, primaria società di consulenza strategica globale con profonda expertise nel settore del lusso.
I dati e gli ospiti del dibattito
Illustrato da Claudia D’Arpizio, Senior Partner di Bain e sua responsabile globale per moda e lusso, il Monitor ha evidenziato la resilienza del mercato dei vini di alta gamma – che proietta una crescita annua del 4-6% fino al 2030 – pur segnalando una lieve contrazione nel 2024 (-2/-3%) dovuta a fattori congiunturali e a nuovi trend di consumo.
Proprio a partire da questi dati, un vertice organizzato da Altagamma Vini a Vinitaly, lunedì 7 aprile, ha acceso un confronto serrato e approfondito sulle sfide specifiche che attendono l’Italia in questo agone globale. Moderato da Sebastiano Barisoni (Radio24), il dibattito ha visto Matteo Lunelli (Presidente Altagamma e CEO Ferrari Trento), Maurizio Zanella (Presidente Ca’ del Bosco e VP Altagamma), Giampiero Bertolini (CEO Biondi-Santi e Isole e Olena), Enrico Buonocore (CEO Gruppo Langosteria) e Stevie Kim (Managing Partner Vinitaly) esplorare senza reticenze i nodi critici e le possibili strategie per l’alta gamma vinicola italiana.
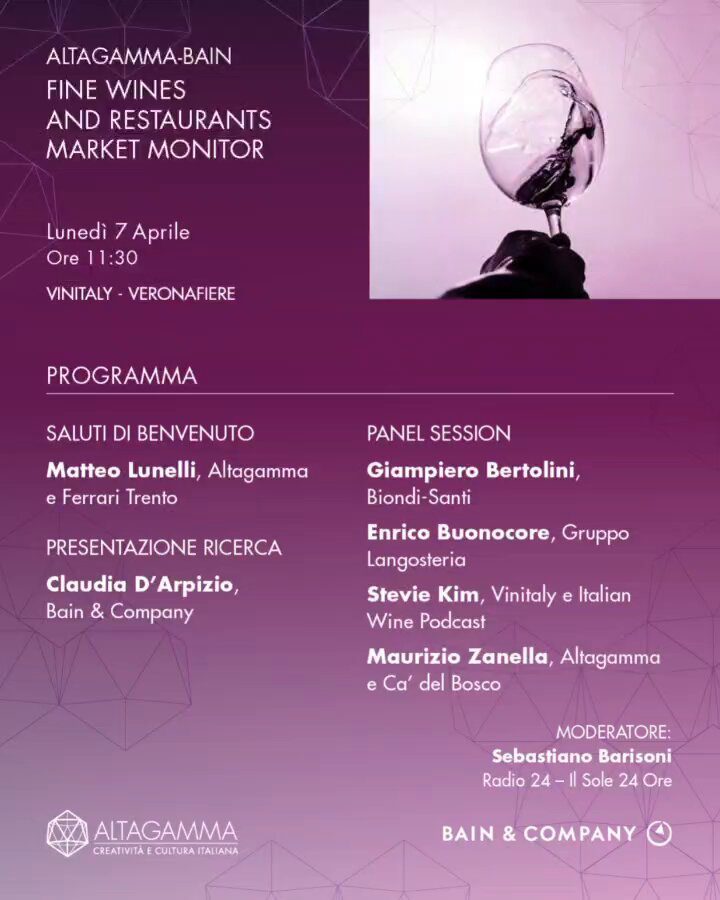
Il benchmark francese: l’alta gamma italiana al vaglio del confronto a Vinitaly
Il paragone con il sistema francese è emerso fin da subito come un passaggio obbligato. Stevie Kim ha chiarito che la questione non è più la qualità intrinseca: il vino italiano, ha affermato, è ormai “altrettanto buono“. La vera differenza, secondo l’esperta italo-coreana alla guida di Vinitaly International, risiede nell’approccio culturale e strategico, quasi antropologico: “la differenza tra popolo italiano e popolo francese“.
I francesi, ha argomentato Kim, hanno dimostrato una capacità storica di fare unione, di muoversi assieme, presentando al mondo un’immagine coesa e facilmente decodificabile. La loro forza comunicativa si basa su pochi, potentissimi nomi-simbolo (Champagne, Bordeaux, Borgogna) e su una struttura produttiva percepita come più semplice, con un numero relativamente limitato di vitigni principali che coprono la stragrande maggioranza della produzione (12 vitigni per l’80% del vino).
L’Italia dell’alta gamma, invece, secondo Kim, riflette la sua anima nazionale: un’esplosione di creatività, passione, un’energia quasi “caotica“, come quella che si può osservare proprio nei padiglioni di Vinitaly. Ma questa vitalità si scontra con un individualismo profondamente radicato, che si traduce in una comunicazione “molto frammentata“. Ogni produttore, ogni territorio, tende a raccontare la propria storia unica, generando un coro di voci magnifiche ma disarticolate, difficili da percepire come un sistema unitario sui mercati internazionali.
Biodiversità e comunicazione: la sfida dell’alta gamma italiana analizzata a Vinitaly
Al centro di questa sfida comunicativa sta il patrimonio più prezioso e, al contempo, più problematico dell’Italia enologica: la sua straordinaria biodiversità. Maurizio Zanella ha parlato con orgoglio di un “giacimento che i francesi invidiano“, riferendosi agli oltre 600 vitigni autoctoni e alle più di 400 denominazioni che costellano la penisola.
Ma Stevie Kim ha offerto una prospettiva più pragmatica, definendo questa stessa ricchezza “il problema“, data la sua “eccessiva complessità“. Come comunicare efficacemente questa miriade di nomi, storie, terroir a un pubblico globale? Secondo Kim, è come dover imparare “una lingua nuova” per ogni singola area, un compito improbo che rischia di confondere irrimediabilmente il consumatore finale, specialmente quello meno esperto che si affaccia al mondo dei vini di alta gamma.
Barisoni: piccolo non è sempre sinonimo di bello
Sebastiano Barisoni ha ulteriormente approfondito questa critica, mettendo in discussione il mantra del “piccolo è bello“, così caro a una certa retorica del Made in Italy. Richiamando un parallelo con l’evoluzione dell’industria manifatturiera, ha distinto nettamente tra l’essere piccoli per scelta strategica, trovando una collocazione precisa nella catena del valore, e l’essere semplicemente “nani” in un contesto globale. “Se il tuo concorrente ha 10 volte le tue dimensioni“, ha avvertito, la piccolezza diventa una vulnerabilità strutturale.
Il rischio, secondo il moderatore, è “innamorarsi delle categorie“, aggrapparsi a concetti come “terroir, specificità, unicità” fino a farli diventare un ostacolo alla comunicazione efficace. Un’eccessiva frammentazione del messaggio, pur partendo dalla valorizzazione di unicità reali, finisce per “confondere il consumatore” e indebolire la percezione complessiva dell’alta gamma italiana.
“Massa critica” per l’alta gamma: l’unità mancata al centro del dibattito Vinitaly-Altagamma
La logica conseguenza di questa diagnosi di frammentazione, emersa con forza nel dibattito a Vinitaly, è la riconosciuta necessità strategica per l’alta gamma italiana di “fare massa critica”, ovvero di presentarsi sui mercati internazionali con maggiore coesione e forza d’urto.
Bertolini: il lavoro di gruppo è imprescindibile
Giampiero Bertolini ha pienamente condiviso questa esigenza, sottolineando come, specialmente in mercati cruciali ma ancora poco presidiati come l’Asia, un “lavoro di gruppo” sia ormai imprescindibile. Ha portato come esempio il successo storico del Cognac, dimostrazione di come una strategia collettiva e paziente possa costruire una forte riconoscibilità e penetrazione di mercato. Un percorso, tuttavia, che Bertolini ha ammesso con realismo non venire spontaneo al sistema italiano.
C’è bisogno, ha spiegato, di un impegno concertato per migliorare la sinergia già a livello dei singoli consorzi, ma l’ideale, per presentarsi con “una certa forza“, sarebbe riuscire a costruire un coordinamento ancora più efficace su scala regionale. Tuttavia, la strada verso l’unità appare disseminata di ostacoli interni. Lo stesso Bertolini ha offerto una testimonianza diretta e quasi sconsolata delle difficoltà di coesione all’interno della sua stessa regione, la Toscana: “io non rappresento certo l’esempio di una regione in cui andiamo d’accordo“.
Zanella: una cabina di regia nazionale
Maurizio Zanella ha invocato la necessità di una “cabina di regia” nazionale che possa orchestrare la promozione dell’alta gamma italiana, evitando le dannose “guerre tra regioni” che bruciano risorse in competizioni fratricide anziché concentrarsi sui mercati esteri. La logica suggerirebbe di promuovere prima il “sistema Italia” e poi le sue specificità, ma Bertolini ha realisticamente constatato che, al momento di tradurre questa logica in pratica, emergono quasi sempre “reticenze interne” alle singole denominazioni che bloccano ogni progresso significativo.
Zanella, tuttavia, ha voluto anche spezzare una lancia a favore della complessità italiana, vista non solo come problema ma anche come valore strategico nel lungo periodo. Richiede più sforzo, “bisogna sudare di più” per comunicarla, ha concesso, ma rappresenta un patrimonio unico. Ha anche invitato a non idealizzare eccessivamente il modello francese, ricordando come persino in Borgogna, spesso, siano i singoli cru ad avere più notorietà e forza di mercato rispetto alla denominazione regionale generica. Di qui la sua netta opposizione a strategie di comunicazione eccessivamente semplificatorie, come ipotetiche campagne indifferenziate sulle “bolle italiane”, che metterebbero insieme realtà troppo diverse, come “mele e pere“, tradendo la ricchezza qualitativa dell’alta gamma spumantistica italiana.

Alta ristorazione: palcoscenico strategico per i vini di alta gamma
I dati presentati a Vinitaly da Altagamma e Bain non lasciano dubbi: l’alta ristorazione è un veicolo fondamentale per il posizionamento e la vendita dei vini di alta gamma. Ma è un mondo con regole e criticità proprie, come ha testimoniato con passione Enrico Buonocore. Il fondatore di Langosteria ha denunciato quella che definisce una “timidezza” culturale profondamente italiana, una sorta di complesso di inferiorità che si manifesta all’estero. Ha descritto il paradosso di ristoranti italiani che privilegiano i vini francesi nelle loro carte, mentre i locali francesi non esitano a proporre le migliori etichette italiane.
Le linee guida della Langosteria
Un problema di approccio, di mancanza di consapevolezza del proprio valore. La sua missione dichiarata è proprio quella di superare questo limite, esportando un modello di “italianità organizzata“, che coniughi l’eccellenza gastronomica e l’inimitabile calore dell’ospitalità italiana con un rigore gestionale quasi “svizzero-tedesco“.
Il successo internazionale del suo format (Parigi, St. Moritz, prossime aperture a Londra e Madrid) si basa, ha spiegato Buonocore entrando nei dettagli, su un investimento costante e mirato su tre elementi chiave.
Primo, le persone: “costruire persone“, attrarre talenti esterni ma soprattutto far crescere internamente figure manageriali capaci di gestire i locali con autonomia e spirito imprenditoriale.
Secondo, le location: una strategia precisa che punta a luoghi iconici e prestigiosi nelle capitali mondiali del lusso.
Terzo, i processi: pur rifiutando categoricamente una standardizzazione “alla McDonald’s” che snaturerebbe l’essenza dell’esperienza. Buonocore crede fermamente nell’importanza del metodo, dei manuali operativi, del controllo di gestione, dell’uso strategico della tecnologia per garantire un livello di servizio costantemente eccellente.
Ha anche sottolineato l’impatto decisivo dei “primi tre minuti” dell’accoglienza sull’intera percezione del cliente e sulla sua disponibilità a vivere un’esperienza completa, inclusa la scelta di un vino di alta gamma. Buonocore ha inoltre sollevato un problema concreto che affligge la competitività dei vini di alta gamma italiani all’estero: i ricarichi spesso impraticabili applicati dai distributori locali.
Stevie Kim: gli chef stellati snobbano il vino
Tuttavia, il rapporto tra vini di alta gamma e alta cucina presenta anche frizioni significative. Stevie Kim ha raccontato senza mezzi termini la sua “grande delusione” nello scoprire l’indifferenza, se non il fastidio di molti chef stellati nei confronti del vino, percepito come secondario rispetto alla centralità del piatto. Questo implica, ha suggerito, che la strategia dei produttori di alta gamma debba focalizzarsi sempre più sulle figure emergenti dei Wine Director e sui sommelier.
A questa critica si è aggiunta quella, vivace, del moderatore Barisoni, che ha stigmatizzato certi atteggiamenti di supponenza o la palese impreparazione riscontrati talvolta nel personale di sala anche in ristoranti di altissimo livello.
Leve strategiche per l’eccellenza italiana: le proposte dal vertice Altagamma a Vinitaly
Quali dunque le vie d’uscita? Quali le strategie concrete emerse dal confronto a Vinitaly? Diverse leve sono state messe a fuoco.
È emersa la necessità di fare maggiormente leva su organismi capaci di rappresentare il sistema, come Fondazione Altagamma. Giampiero Bertolini l’ha definita una “associazione straordinaria“, già capace di veicolare all’estero un “messaggio unico” grazie alla sua coerenza di posizionamento, un lavoro che può essere “ancora potenziato“.
Bertolini ha caldeggiato con particolare enfasi la strategia dell’ospitalità qualificata. Invitare buyer, giornalisti e influencer a vivere l’esperienza direttamente nei territori di produzione dell’alta gamma italiana ha, secondo lui, un’efficacia impareggiabile. “Portare persone qui“, ha affermato, le trasforma nei migliori amplificatori del messaggio; l’esperienza diretta cambia completamente la relazione con questi interlocutori chiave, risultando forse più produttiva di costose missioni collettive all’estero.
Stevie Kim: creare due tipi di comunicazione
L’investimento sulle persone è cruciale. Stevie Kim ha dettagliato l’impegno della Vinitaly International Academy nel creare una rete globale di “ambasciatori” certificati (438 in 52 paesi, formati con un processo selettivo rigoroso), capaci di spiegare e promuovere la complessità dell’alta gamma italiana. Kim ha insistito sulla necessità di una comunicazione differenziata: un linguaggio per il grande pubblico, uno più tecnico e approfondito per gli “addetti ai lavori”, ritenuti “estremamente importanti“.
Maurizio Zanella: il patrimonio Unesco della cucina italiana
Maurizio Zanella ha sottolineato l’importanza straordinaria che potrebbe rivestire il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio UNESCO. Non si tratterebbe di un semplice titolo, ma di un potente strumento per innescare un meccanismo virtuoso di miglioramento qualitativo e di rafforzamento dell’orgoglio nazionale, dalla piccola trattoria all’estero fino ai produttori di alta gamma, intercettando al contempo la crescente domanda di autenticità da parte del turismo internazionale.
Enrico Buonocore: ci vuole più coraggio
L’appello accorato di Enrico Buonocore a una maggiore superbia – intesa come sana autostima, fiducia nel proprio valore – e a una più profonda consapevolezza, deve, secondo molti, diventare un imperativo per l’intero sistema dell’alta gamma italiana, per scrollarsi di dosso quella timidezza che ne limita l’affermazione sui mercati globali.
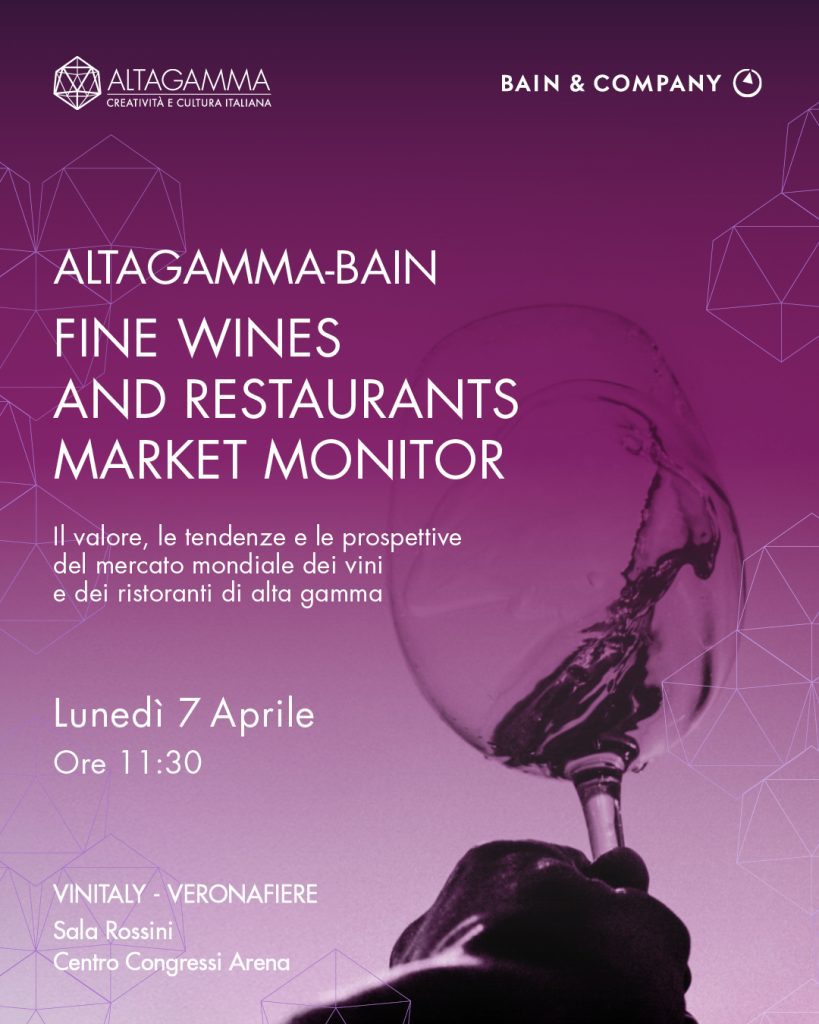
Le nuove sfide: il vino dealcolato e la competizione sui format globali
Il dibattito ha anche affrontato le sfide poste dalle nuove tendenze. Riguardo ai prodotti dealcolati, la posizione espressa da Maurizio Zanella è stata ferma nel distinguere nettamente questa categoria dal vino propriamente detto, specialmente quello di alta gamma.
Pur senza demonizzare il mercato dei prodotti a basso o nullo contenuto alcolico, ha ribadito che è un “madornale errore” chiamarli “vini” e che essi non possono e non devono far parte del mondo del vino di qualità e a denominazione, per non comprometterne l’identità e il posizionamento.
Ha tuttavia riconosciuto, con realismo, che la domanda esiste ed è spinta da fattori salutistici e culturali, al punto che persino ristoranti di alta gamma in città internazionali come Londra potrebbero sentirsi “obbligati” a inserirli nelle loro carte.
Matteo Lunelli, nel suo ruolo di Presidente di Altagamma, ha lanciato un importante monito strategico relativo al mondo della ristorazione. Ha osservato come grandi gruppi internazionali stiano iniziando a investire massicciamente nello sviluppo di format basati sulla cucina italiana di alto livello. Per l’Italia, ha avvertito, è “fondamentale” non restare spettatrice ma diventare protagonista di questa tendenza, “costruendo format di ristorazione italiana” forti, autentici e scalabili, capaci di rappresentare al meglio l’eccellenza nazionale e di valorizzare appieno i vini di alta gamma del paese nel contesto globale.
L’ultimo ostacolo strutturale: il nodo della distribuzione
A conclusione di un dibattito così ricco, Sebastiano Barisoni ha voluto porre l’accento su un’ultima, ma fondamentale, debolezza strutturale che affligge il settore vinicolo di alta gamma più di altri comparti del lusso: la forte dipendenza, specialmente sui mercati di esportazione più importanti come gli Stati Uniti, dalla lunga e complessa catena degli importatori e distributori.
Questo modello, a differenza del retail diretto che la moda ha saputo sviluppare con successo, limita fortemente il controllo dei produttori sulla strategia di prezzo finale, sul posizionamento sugli scaffali o nelle carte dei vini, e sui margini complessivi, rendendo l’intero sistema più vulnerabile alle dinamiche distributive e a fattori esterni.
Il vertice Altagamma tenutosi a Vinitaly ha quindi offerto uno spaccato profondo e sfaccettato dello stato dell’arte e delle prospettive future per i vini di alta gamma italiani. Ne emerge l’immagine di un settore dal potenziale immenso, forte di una qualità indiscussa e di una diversità unica al mondo, ma ancora alla ricerca di una strategia collettiva efficace e di una maggiore consapevolezza di sé per affrontare con successo le sfide del mercato globale del lusso.
Superare la frammentazione, migliorare la comunicazione, investire sulle persone e sull’esperienza, e non da ultimo, coltivare un sano orgoglio nazionale: questi appaiono come i passaggi obbligati per permettere all’eccellenza enologica italiana di esprimere finalmente tutto il suo valore. La strada è tracciata, le sfide identificate: il futuro dell’alta gamma dei vini italiani dipenderà dalla capacità del sistema di rispondere con visione, coraggio e, soprattutto, coesione.
