Il Moscato che non ha senso: il successo di XXL svela il futuro del mercato?
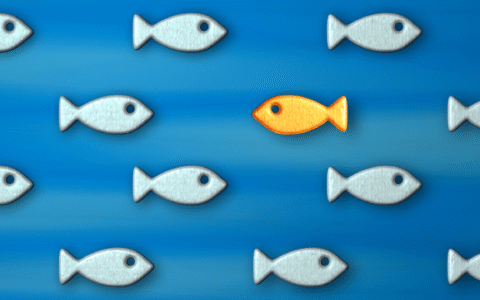
La critica Esther Mobley ha definito (retoricamente) “insensato” il boom di un vino dolce e superalcolico nell’era della moderazione. Ma dietro al fenomeno XXL si cela una lezione cruciale sul mercato americano: la spaccatura tra due poli opposti, benessere e indulgenza, sta diventando così profonda da lasciare un vuoto nel mezzo.
Nel suo articolo per il San Francisco Chronicle, la critica enologica Esther Mobley ha messo il dito nella piaga di un’industria confusa. “La crescente popolarità di questo vino ad alta gradazione non ha alcun senso“, ha scritto, fotografando il paradosso che sta definendo il mercato delle bevande negli Stati Uniti. Da un lato, una spinta inarrestabile verso prodotti a bassa gradazione o analcolici. Dall’altro, il successo esplosivo di XXL, un Moscato fortificato al 16% di alcol, che è passato da 85.000 a 2,5 milioni di casse in soli due anni. Un fenomeno che, analizzato a fondo, smette di essere “insensato” per diventare un potente indicatore del futuro.
Un mercato definito dal benessere
Per cogliere la portata della scommessa di XXL, è necessario guardare al contesto da cui fugge. Il mercato del vino tradizionale americano, come nota Mobley, è in declino strutturale, specialmente nella fascia sotto i 15 dollari. L’unica vera crescita è trainata dalla cultura del benessere. I consumatori più giovani, Millennial e Gen Z, sono “sobriamente curiosi” e vedono l’alcol con cautela, associandolo ad ansia e vulnerabilità. Questo ha creato un fiorente mercato per alternative analcoliche premium, spesso vendute a prezzi superiori (22-36$), dove la scelta di cosa bere diventa una dichiarazione dei propri valori salutisti.
La ribellione controcorrente
È proprio in reazione a questo scenario che nasce XXL. Come riporta Mobley, l’idea è venuta al CEO di Tri-Vin Imports, Marc Oliveira, dopo aver partecipato a un panel di settore in cui tutti celebravano il no/low come unica via. La sua è stata una ribellione calcolata, basata su un’intuizione precisa: se tutti vanno nella stessa direzione, si crea un vuoto altrove. Quel vuoto era il mercato dei vini fortificati e aromatizzati, un segmento che, contro ogni previsione, è in crescita e si stima supererà i 6 miliardi di dollari negli USA entro il 2030.
Anatomia di un fenomeno
Il prodotto creato da Oliveira è un capolavoro di ingegneria commerciale. Con una gradazione alcolica al limite legale per i supermercati (molti stati permettono la vendita di vino nei supermercati ma relegano i superalcolici a negozi specializzati e controllati) e un prezzo accessibile (10-13$), XXL offre un eccezionale rapporto effetto/prezzo. La scelta di Oliveira di fissare la gradazione del suo prodotto principale a 16% non è casuale, anzi, è una decisione strategica fondamentale per massimizzare la distribuzione.
Rimanendo al limite del 16%, XXL riesce sia a essere presente sugli scaffali dei supermercati sia a ottenere un vantaggio competitivo: se un concorrente volesse superarlo creando un prodotto al 17% o 18%, quel prodotto non potrebbe più essere venduto nella maggior parte dei supermercati. Finirebbe in un canale di vendita diverso e molto più ristretto.
Lo slogan, “Moscato without manners” (Moscato senza buone maniere), è una dichiarazione d’intenti: un invito esplicito a un divertimento senza pretese, in netta contrapposizione sia con l’etichetta del vino tradizionale sia con il salutismo imperante.
Esplosione virale e stroncatura della critica
Il successo del brand non è passato per i canali tradizionali, ma è esploso su TikTok. Video di utenti sorpresi dalla sua potenza (“sa di succo ma è forte come un liquore“) sono diventati virali, creando un passaparola più efficace di qualsiasi pubblicità. Ma, come sottolinea Mobley nel suo pezzo, a questo entusiasmo popolare corrisponde un netto rifiuto da parte degli esperti. Una degustazione nella sua redazione ha prodotto una “quasi universale repulsione“, descrivendo il vino come eccessivamente dolce e sciropposo.
Lezione dal mercato: la fine del “centro” americano
Qui risiede il punto cruciale. Il caso XXL non nega la tendenza alla moderazione; la conferma, mostrandone il rovescio della medaglia. Il mercato americano si sta spaccando, lasciando un vuoto incolmabile nel mezzo. Da un lato, c’è il polo del benessere. Dall’altro, quello dell’indulgenza. La vera lezione, che l’articolo di Mobley aiuta a mettere a fuoco, è la morte del “centro torbido“. I vini da tavola generici, a prezzo medio, che non offrono né benessere né un’esperienza d’impatto, stanno perdendo terreno. Non parlano più a nessuno dei due poli emergenti.
Il successo di XXL dimostra che esiste un’enorme opportunità commerciale nel servire, senza scuse né complessi, quel pubblico che cerca semplicemente un prodotto divertente, potente e conveniente. Per i marchi del futuro, la scelta sembra obbligata: o si compete sul benessere o sull’indulgenza.
E in Italia?
In Italia una dinamica simile è improbabile. Sebbene anche il nostro mercato si stia polarizzando, il nostro polo dell’indulgenza è definito da valori culturali opposti: non la potenza a basso costo, ma l’autenticità e la complessità. Dove il consumatore americano privilegia il brand, quello italiano è ancora legato al terroir. È questo cuscinetto culturale a rendere la storia di XXL un affascinante, ma lontano, fenomeno americano.
Questa unicità, tuttavia, non rende il mercato italiano immune alle trasformazioni. Al contrario, sta vivendo una propria, profonda polarizzazione, i cui contorni sono definiti da dinamiche unicamente italiane.
La “grande divergenza” del mercato italiano
Il quadro attuale è definito da una grande divergenza. Da un lato, i dati raccontano una storia di contrazione: il consumo interno di vino è in calo strutturale, con le vendite nella grande distribuzione che hanno perso il 4% nel primo trimestre del 2025 e le cantine che si ritrovano con scorte in eccesso, equivalenti a un’intera vendemmia.
Dall’altro lato, emerge una narrazione di successo: l’export ha superato gli 8 miliardi di euro nel 2024, trainato da una chiara strategia di premiumizzazione. Il mantra del settore è diventato vendere meno, ma vendere meglio. Questa spaccatura è ancora più evidente tra le tipologie di vino: mentre i rossi da pasto, un tempo pilastro della tavola, sono in crisi, il mondo delle bollicine e dei vini bianchi è in piena espansione.
I poli della scelta: benessere e indulgenza culturale
La polarizzazione italiana si manifesta, dicevamo, su un asse diverso da quello americano.
Da un lato il polo del benessere: l’ascesa dei vini a bassa gradazione o analcolici (No-Lo) è la novità più dirompente. Fino a poco tempo fa osteggiata, la produzione di vini dealcolati è stata finalmente autorizzata in Italia all’inizio del 2025, non per spinta interna, ma perché trainata dalla domanda dei consumatori. Le motivazioni sono chiare: la ricerca di uno stile di vita più sano e necessità pratiche, come le preoccupazioni legate al nuovo Codice della Strada. Sebbene sia ancora una nicchia, si prevede che la produzione crescerà del 60% solo quest’anno, segnalando un cambiamento irreversibile.
Dall’altro, il polo dell’indulgenza: qui risiede la nostra più grande differenza. L’indulgenza del consumatore italiano non cerca l’effetto, ma l’esperienza. È culturale e qualitativa. Si esprime nella scelta di vini complessi, tradizionali e di alta gradazione naturale. In questi vini, la gradazione alcolica è il risultato di un terroir, di una tradizione (come l’appassimento) e di una ricerca di complessità. Il valore non è nella potenza, ma nell’autenticità, una visione che rende un prodotto come XXL culturalmente incompatibile con il nostro mercato.
La generazione fluida: il motore del cambiamento
A guidare questa polarizzazione sono le nuove generazioni, che non possono essere ridotte al cliché della generazione sobria. I Millennial e la Gen Z dimostrano un comportamento fluido, operando in modalità diverse a seconda dell’occasione.
Un giovane consumatore può essere un moderatore consapevole a un pranzo di lavoro, scegliendo un’opzione analcolica, per poi trasformarsi in un edonista esperienziale nel weekend, investendo in una bottiglia importante per una cena speciale. Per il 56% di loro, il vino è uno status symbol. È questa capacità di passare da un polo all’altro che spiega la crescita simultanea del mercato No-Lo e di quello dei vini ultra-premium. Hanno svincolato il vino dal suo ruolo di alimento quotidiano per trasformarlo in uno strumento per raggiungere obiettivi diversi: benessere, affermazione sociale o piacere culturale.
La crisi del vino quotidiano e il futuro del “centro”
Questa trasformazione dei consumi porta con sé una vittima eccellente: il vino quotidiano. Il suo crollo non è solo un dato economico, ma il sintomo di un cambiamento culturale profondo. Il vino non è più un alimento sulla tavola di tutti i giorni, ma è diventato un prodotto di scelta attiva per occasioni specifiche.
Cosa ne è, quindi, del vasto mondo dei vini di qualità che si colloca tra i due estremi? Quel “centro” che in Italia non è indifferenziato, ma è un mosaico di centinaia di denominazioni e vitigni autoctoni? La sua non è una strategia destinata al declino, ma una sfida di comunicazione e di valorizzazione. In un mercato dove l’attenzione è catturata dai poli, la sopravvivenza di questo patrimonio dipenderà dalla sua capacità di raccontare la propria unicità. Dovrà trasmettere efficacemente il valore di un’esperienza che né un prodotto del benessere né uno dell’indulgenza di massa possono offrire: l’autentica espressione di un territorio.
