Mitteleuropa o Impero Asburgico? Una nuova chiave di lettura per i vini del cuore d’Europa
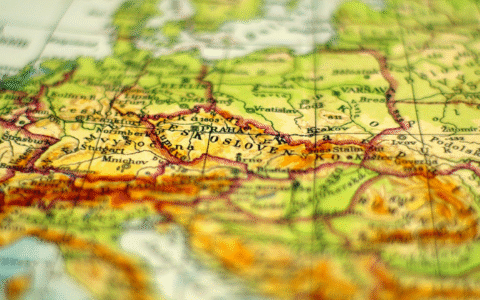
Cosa si cela veramente dietro l’etichetta, spesso ambigua, di “Europa Centrale” quando si parla di vino? Per l’esperto Simon J Woolf, la risposta trascende la semplice geografia per affondare le radici nella storia e nella cultura, riscoprendo nell’ex Impero Asburgico il vero e sorprendente tessuto connettivo di una galassia di tradizioni vinicole. Un’eredità oggi in vibrante rinascita, sovente sotto il vessillo del vino naturale e della riscoperta identitaria.
Quale sia la vera essenza dei “Balcani”, o dove esattamente si collochino: è la domanda provocatoria posta dal filosofo sloveno Slavoj Žižek in un suo celebre intervento, che ci ricorda quanto siano sfuggenti e carichi di implicazioni i termini geografici che usiamo quasi per inerzia.
Allo stesso modo, Simon J Woolf, autore e profondo conoscitore del panorama enoico internazionale, ammette di aver a lungo fatto ricorso all’espressione “Europa Centrale” – o, per darsi un tono più sofisticato, Mitteleuropa – per abbracciare quel mosaico di nazioni vinicole che stimolano la sua curiosità culturale e deliziano il suo palato: l’Austria, l’Ungheria, la Slovenia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Croazia, la Serbia, la regione dell’Erzegovina (storica area vinicola della Bosnia ed Erzegovina), e altre ancora. Tuttavia, come Woolf stesso argomenta con lucidità, questa etichetta, per quanto pratica, si rivela un vero e proprio enigma, quasi insolubile, se applicata con la pretesa di definire un’identità vinicola univoca.
Il termine Mitteleuropa, cristallizzatosi a metà Ottocento con l’ascesa di una società industrializzata e colta gravitante attorno alla Germania moderna, è tutt’altro che una semplice designazione geografica. Divenne progressivamente un descrittore aspirazionale per i paesi a est dell’asse germanico, portando con sé anche connotazioni etniche, relative all’incontro tra culture slave e germaniche. Un amalgama che, non a caso, costituiva il tessuto sottostante dell’Impero Asburgico. Due guerre mondiali resero però il termine politicamente controverso, e la successiva Guerra Fredda, con la Cortina di Ferro a dividere Est e Ovest, sembrò seppellire definitivamente ogni idea di un’Europa Centrale unita. Eppure, il concetto è riemerso negli anni ’90 come descrittore positivo per le nazioni ex-jugoslave, in particolare Serbia e Bosnia-Erzegovina, legate sia all’Impero Asburgico (poi Austro-Ungarico) sia all’aspirazione di entrare nell’Unione Europea.
Le definizioni ufficiali, tuttavia, tendono a rimanere ancorate a una visione geografica tradizionale, che include quasi sempre Germania e Svizzera, e talvolta i Paesi Baltici, escludendo gran parte dei Balcani o delle nazioni ex-jugoslave, con la Slovenia spesso considerata un caso limite. Un approccio, secondo Woolf, di scarsa utilità per chi cerca i nessi culturali profondi che legano le diverse terre da vino. “È da un pezzo che non bevo un vino lituano,” chiosa ironicamente, notando come la viticoltura e la geografia elvetica appaiano più intimamente connesse alla Francia. Anche i parallelismi tra la Germania e le regioni ex-asburgiche gli appaiono forzati: la tradizione enologica tedesca è spiccatamente nord-europea, universalmente nota per i suoi bianchi e priva, ad esempio, di una documentata tradizione di macerazione sulle bucce per le uve bianche. La Germania vanta, inoltre, una storia ben più lunga di vini di qualità imbottigliati e un sistema di classificazioni e denominazioni più consolidato rispetto ai suoi vicini orientali e meridionali. Paradossalmente, sottolinea Woolf, i vignaioli tedeschi hanno mostrato una più lenta adozione delle filosofie del minimo intervento e del vino naturale, se confrontati con l’evoluzione in Austria, Italia o Slovenia.
La vera svolta nella comprensione di Woolf avviene attraverso la sua passione per gli “orange wine”. Questi vini bianchi, ottenuti da una prolungata macerazione del mosto con le bucce, gli hanno svelato l’esistenza di un importante asse enoculturale che si snoda attorno all’Alto Adriatico. Territori del Nord-Est italiano come il Collio friulano, il Carso e l’area triestina, infatti, sono etnicamente e culturalmente tanto slavi quanto italiani. Qui, la tradizione dei bianchi macerati affonda le radici in secoli di storia, prosperando su entrambi i versanti del confine italo-sloveno. L’Istria, oggi divisa tra Slovenia e Croazia, celebra la sua identità plurale attorno a un bicchiere di Malvasija, quasi sempre accompagnato da un invitante piatto di pasta. Spostandosi all’altro capo della Slovenia, invece, il paesaggio, la cucina e lo stile dei vini cambiano registro, avvicinandosi sensibilmente al mondo austriaco: la Stiria austriaca (Steiermark) e la Štajerska slovena sono, a tutti gli effetti, un’unica, grande regione vinicola separata solo da un confine politico moderno, un’area dove la preferenza è accordata a vini bianchi più leggeri, tesi e aromatici.
È proprio l’Austria, per Woolf, a rappresentare l’autentica “miniera d’oro”, il cuore pulsante del vino naturale in questa specifica porzione d’Europa. Il paese non solo vanta un numero straordinario di produttori che hanno raggiunto fama globale, ma detiene anche la più alta percentuale europea di tenute certificate in regime biologico (un impressionante 24%) ed è considerata la culla dell’agricoltura biodinamica. Essendo una delle poche nazioni dell’alveo ex-asburgico a essere sfuggita all’omologazione e al declino qualitativo imposti dalla produzione vinicola di stampo comunista, l’Austria ha saputo conservare un notevole vantaggio competitivo, forse persino rafforzato dalla crisi e dalla successiva rinascita seguite allo scandalo del vino del 1985.
La chiave di volta per decifrare queste intricate connessioni, suggerisce Woolf, risiede nell’osservare con attenzione una mappa dell’Impero Austro-Ungarico nella sua massima espansione, quella del decennio immediatamente precedente la Prima Guerra Mondiale. Quel complesso costrutto politico e, soprattutto, culturale, che inglobava il Südtirol (l’attuale Alto Adige italiano, isola linguistica prevalentemente tedesca), le già citate aree del Nord-Est italiano, e le cui tradizioni vinicole si irradiavano naturalmente verso la Slovenia, la Croazia, estendendosi fino alla regione dell’Erzegovina e alla Serbia (entrambe importanti realtà produttrici nell’epoca asburgica, con l’Erzegovina che costituiva il fulcro vitivinicolo della Bosnia ed Erzegovina), sembra delineare con sorprendente coerenza l’area di interesse enologico di Woolf. Due devastanti conflitti mondiali e mezzo secolo di storia jugoslava hanno certamente eroso e offuscato molti di questi antichi riferimenti. Tuttavia, oggi si assiste a una faticosa ma entusiasmante riscoperta e a una progressiva ripresa di queste identità vinicole. Woolf stesso condivide con palpabile eccitazione le sue recenti esperienze di degustazione di vini serbi provenienti dalle regioni di Fruška Gora e Negotinska Krajina.
Questa rinascita all’insegna del naturale è particolarmente vibrante e tangibile quando si viaggia dal Weinviertel austriaco in direzione nord, addentrandosi nella Repubblica Ceca. La Moravia, con i suoi pittoreschi villaggi vinicoli caratterizzati dalle tipiche kellergasse (le vie fiancheggiate da piccole cantine scavate nel terreno), appare come una naturale e armoniosa prosecuzione della regione austriaca. Qui, sopravvivono ancora vecchi vigneti coltivati a gemischtersatz, l’antico uvaggio tradizionale di diverse varietà vendemmiate e vinificate insieme, a eloquente testimonianza di come questa pratica fosse un tempo diffusa ben oltre i confini della moderna Vienna. Sia la Repubblica Ceca che la vicina Slovacchia hanno dovuto affrontare un arduo e lungo percorso di ricostruzione di un’industria vinicola letteralmente messa in ginocchio dalla produzione massificata e di scarsa qualità tipica dell’era comunista. Ma oggi, una nuova ed eccitante era è decisamente in corso, trainata con passione e competenza da piccole tenute artigianali, fortemente orientate al basso intervento in vigna e in cantina. Questo fermento ha portato a una situazione quasi unica nel panorama mondiale: i produttori di vino naturale di queste nazioni godono spesso di un profilo e di una riconoscibilità internazionale ben più marcati rispetto alle loro controparti più convenzionali, queste ultime solitamente più focalizzate sul mercato interno. Nomi come quello di Milan Nestarec in Moravia o di Strekov 1075 in Slovacchia hanno letteralmente proiettato questi paesi sulla mappa enologica globale, grazie alla loro capacità di creare vini di incredibile freschezza, bevibilità e vitalità, autentica espressione di un clima ancora genuinamente fresco e marcatamente continentale.
In Ungheria, il percorso di rinascita si è rivelato più articolato. Se da un lato la secolare e meritata fama dei vini dolci di Tokaj ha garantito al paese una presenza costante e prestigiosa sulla scena internazionale, dall’altro la regione si è per lungo tempo adagiata su allori ormai sbiaditi dopo il crollo della Cortina di Ferro, con vigneti abbandonati e pratiche enologiche trascurate. Una comunità di viticoltori dediti al naturale si è sviluppata più lentamente rispetto ad altre aree, ma oggi rappresenta una realtà solida e dinamica, con produttori del calibro di Peter Wetzer, Szolo, Reka Koncz e Bencze Birtok che ne portano alta la bandiera.
Più Woolf approfondisce la sua analisi e osserva la mappa dell’Impero Austro-Ungarico, più si rafforza in lui la convinzione che il suo vero faro, la sua bussola enologica, non sia tanto una generica e sfuggente “Europa Centrale”, quanto piuttosto l’ex Impero Asburgico: un’entità storica e un’epoca che hanno impresso un marchio profondo e indelebile sulla cultura del vino in tutta questa vasta e multiforme porzione d’Europa. L’influenza, sottolinea con acume, si estende ben oltre il mondo del vino: l’architettura di città come Timișoara, nella Romania occidentale (anch’essa, un tempo, sotto il dominio asburgico), o la capillare diffusione di specialità culinarie come il Goulash e lo Strudel in innumerevoli varianti regionali, sono altrettante testimonianze viventi di questa profonda e condivisa eredità culturale.
“Ridefinirmi da specialista dell’Europa Centrale a ‘ossessivo della ex Monarchia Asburgica’ potrebbe non suonare particolarmente accattivante o commerciale,” ammette Woolf con un pizzico di autoironia, “ma è, senza dubbio, la descrizione geopolitica che meglio si adatta e che più fedelmente rispecchia i paesi che continuano a ispirarmi, a spingermi a viaggiare, a ricercare e, infine, a scrivere.” Per Woolf, gran parte di ciò che un tempo costituiva l’Impero Austro-Ungarico rimane, per molti appassionati, un territorio vinicolo ancora largamente inesplorato, un tesoro nascosto. La sua è una missione dichiarata, quasi un manifesto programmatico: contribuire con passione a cambiare questa percezione, invitando tutti gli amanti del vino a seguirlo in questa affascinante e gratificante avventura di riscoperta.
